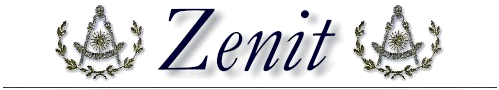
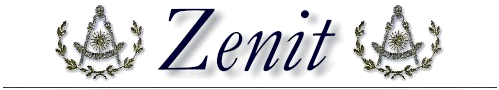
![]()

Honoré de Balzac
Claes L’Alchimista
(La Recherche De L’Absolu)
Quinta parte
Baldassarre la guardò con aria stupita.
– Pensi alle tue esperienze? – essa riprese.
Egli rispose con un gesto di terribile vivacità. Invece di muovergli rimprovero, la signora Claes che aveva, a suo agio, sondato l’abisso nel quale stavano per precipitare tutti e due, gli prese la mano e gliela strinse sorridendo:
– Grazie amico, sono sicura del mio potere – gli disse: – tu mi hai sacrificato più che la tua vita. Tocca a me ora il sacrificio! Per quanto io abbia già venduto alcuni dei miei diamanti ce ne sono ancora abbastanza, se vi aggiungo quelli di mio fratello, per procurarti il denaro necessario ai tuoi lavori. Destinavo questi finimenti alle nostre due figliole, ma la tua gloria non ne procurerà a loro di più splendidi? D’altra parte non restituirai loro un giorno diamanti più belli?
La gioia che improvvisamente illuminò il viso di suo marito segnò il colmo della disperazione per Giuseppina: essa constatò, e con dolore, che la passione di quest’uomo era più forte di lui. Claes aveva fiducia nella sua opera tanto da incamminarsi, senza tremare, su di una via che per sua moglie era un abisso. A lui la fede, a lei il dubbio, a lei il fardello più pesante. La donna non soffre forse sempre per due? E in questo momento essa volle credere al successo volendo giustificare a se stessa la sua complicità nel probabile sperpero dei loro beni.
– L’amore di tutta la vita non sarebbe sufficiente a contraccambiare la tua devozione, Pepita – disse Claes commosso.
Aveva appena terminato queste parole che Margherita e Felicita entrarono per augurare il buon giorno. La signora Claes chinò gli occhi, e restò per un momento interdetta davanti ai figli la cui fortuna era appena stata alienata a favore di una chimera; mentre suo marito li prese allegramente sulle ginocchia chiacchierando lietamente con loro, felice di poter sfogare la gioia da cui era invaso. La signora Claes da quel momento partecipò alla vita ardente del marito. L’avvenire dei figli, la considerazione del padre furono due stimoli altrettanto potenti come per Claes la gloria e la scienza. Così questa donna disgraziata non ebbe più un’ora di tranquillità da quando tutti i diamanti della casa, per mezzo dell’abate de Solis, suo direttore spirituale, furono venduti a Parigi e i fabbricanti di prodotti chimici ebbero ripreso le loro spedizioni. Agitati senza posa dal demone della scienza e da questo furore di ricerca che struggeva suo marito, essa viveva in una continua attesa e rimaneva per intere giornate come morta, inchiodata stilla sua poltrona dalla violenza stessa dei suoi desideri che, non trovando come quelli di Baldassarre uno sfogo nei lavori di gabinetto, tormentarono la sua anima infittendo sui suoi dubbi e sui suoi timori.
A momenti, rimproverandosi l’indulgenza per una passione il cui fine era impossibile e che De Solis condannava, si alzava, andava alla finestra del cortile interno e con terrore guardava il camino del laboratorio. Se ne sfuggiva il fumo, lo fissava con disperazione e le idee più opposte agitavano il suo cuore e il suo spirito. Vedeva andarsene in fumo la fortuna dei suoi figli, ma essa salvava la vita del loro padre: renderlo felice non era il suo primo dovere? Quest’ultimo pensiero, per un momento, la calmava. Essa aveva ottenuto il permesso di entrare nel laboratorio e di rimanervi, ma ben presto dovette rinunciare a questa triste soddisfazione. Troppe vive sofferenze provava là, a veder Baldassarre non occuparsi di lei, e anzi sembrar spesso imbarazzato dalla sua presenza; vi provava delle impazienze gelose; crudeli desideri di far saltare la casa; di morire di mille mali mai visti. Lemulquinier divenne allora per lei una specie di barometro: quando lo sentiva zufolare mentre andava e veniva per servire il pranzo o la colazione, indovinava che le esperienze di suo marito erano fortunate e che gli davano speranza di un prossimo successo; se Lemulquinier era scuro in viso, essa gli dava un’occhiata dolorosa; Baldassarre era malcontento. La padrona e il servitore avevano finito per comprendersi ad onta della fierezza dell’una e della burbera sottomissione dell’altro. Debole e senza difesa contro le terribili prostrazioni del pensiero, questa donna veniva meno sotto queste alternative di speranza e di disperazione che per lei si aggravavano anche delle inquietudini della donna amante e delle ansietà della madre tremante per la propria famiglia. Ora essa condivideva quel desolante silenzio che un tempo le agghiacciava il cuore, senza accorgersi dell’aria tetra che incombeva sulla casa, e le giornate intere passavano in questa sala senza un sorriso e spesso senza una parola. Per una triste previdenza materna abituava le due figliole ai lavori domestici e cercava di renderle abbastanza abili in qualche lavoro donnesco perché ne potessero ricavar da vivere nel caso cadessero in miseria. La calma di questo interno nascondeva dunque terribile agitazione. Verso la fine dell’estate Baldassarre aveva divorato tutto il denaro ricavato dai brillanti venduti a Parigi per mezzo del vecchio abate de Solis e si era indebitato di una ventina di mila lire coi Protez e Chiffreville.
Nell’agosto del 1813, quasi un anno dopo la scena colla quale si apre questa storia, Claes aveva fatto qualche bell’esperimento che disgraziatamente non teneva in nessun conto: ma i suoi sforzi erano rimasti senza risultato quanto al principale oggetto delle sue ricerche. Il giorno in cui ebbe esaurito la serie dei suoi lavori il sentimento della sua impotenza lo schiacciò; la certezza di aver dissipato senza frutto somme considerevoli lo fece disperare. Fu una orribile catastrofe. Lasciò il suo granaio, scese lentamente in sala, e venne a gettarsi in una poltrona in mezzo ai suoi figlioli e lì rimase per alcuni momenti come morto, senza rispondere alle domande di cui lo assediava la moglie; le lagrime lo vinsero, e andò a nascondersi nel suo appartamento per non aver testimoni al suo dolore; ma Giuseppina lo seguì e lo condusse in camera sua, dove, solo con lei, Baldassarre diede sfogo alla sua disperazione. Le lagrime d’uomo, le parole di artista scoraggiato, i rimorsi del padre di famiglia assunsero aspetti di terrore, di tenerezza, di follia che fecero più male alla signora Claes di tutti i dolori passati. La vittima consolò il carnefice.
Quando Baldassarre con un terribile tono di convinzione disse: "sono un miserabile, gioco la vita dei miei figli, la tua, e per lasciarvi felici bisogna che mi uccida!" questa parola la colpì al cuore, e siccome la conoscenza che essa aveva del carattere di suo marito le faceva temere che egli non realizzasse subito questo disperato proposito, provò uno di quelle emozioni che sconvolgono la vita dalle radici e che fu tanto più funesta in quanto che Pepita ne contenne sotto una calma ingannevole, i violenti effetti.
– Amico mio, – rispose. – Ho consultato non Pierquin la cui amicizia non è tanto grande perché non abbia qualche segreta soddisfazione nel vederti rovinato, ma un vecchio che per me, si mostra buono come un padre: l’abate De Solis, mio confessore, mi ha dato un consiglio che ci salva dalla rovina. È venuto a vedere i tuoi quadri, e il valore di quelli che ci sono nella galleria può essere sufficiente a pagare tutte le somme ipotecate sulle tue proprietà e ciò che devi ai Protez e Chiffreville, perché senza dubbio hai dei conti da saldare con loro.
Claes fece un segno affermativo chinando il capo, i cui capelli erano divenuti bianchi.
– Il signor De Solis conosce gli Happes e Dunker di Amsterdam – e siccome sono pazzi per i quadri e desiderosi come della gente rifatta di far pompa di un fasto che non è possibile che a case antiche, pagheranno i nostri in tutto il loro valore. Così noi rientreremo in possesso di tutte le nostre rendite e tu potrai, dalla somma che s’avvicinerà ai centomila ducati, detrarre una porzione del capitale per continuare le tue esperienze. Le tue due figlie ed io ci accontentiamo di poco. Col tempo e l’economia riempiremo con altri quadri le cornici vuote, e tu sarai felice.
Baldassarre alzò il capo verso la moglie con una gioia mista a timore. Le parti erano invertite. La moglie diveniva la protettrice del marito. Questo uomo così tenero e il cui cuore batteva all’unisono con quello della sua Giuseppina, la teneva fra le braccia senza accorgersi dell’orribile convulsione che la scuoteva tutta agitandole i capelli e le labbra in un tremito nervoso.
– lo non osavo dirti che fra me e l’assoluto c’è solo un filo di distanza. Per gasificare i metalli non manca che di trovare il mezzo di sottoporli all’azione di un calore immenso in un ambiente dove la pressione dell’atmosfera sia nulla; in un vuoto assoluto, insomma.
La signora Claes non poté sopportare l’egoismo di questa risposta. S’aspettava dei ringraziamenti appassionati per i suoi sacrifici e si trovava un problema di chimica.... Lasciò bruscamente il marito, scese in sala e si gettò sulla poltrona fra le due figliole spaventate e scoppiò in pianto; Margherita e Felicita le presero ciascuna una mano, si inginocchiarono ai lati della poltrona piangendo come la madre, senza saper la causa del suo dolore, e le chiesero ripetutamente:
– Che cosa avete, mamma?
– Povere figliole! Sono morta, lo sento.
Questa risposta fece rabbrividire Margherita che per la prima volta, scorse sul viso della madre le tracce del pallore speciale delle persone di tinta bruna.
– Marta, Marta – gridò Felicita – venite, la mamma ha bisogno di voi...
La vecchia governante accorse dalla cucina e vedendo il livido pallore del viso leggermente chiazzato e così acceso:
– Corpo del Cristo! – gridò in spagnolo – la signora muore.
E uscì precipitosamente; disse a Josette di far scaldare dell’acqua per un pediluvio, e ritornò dalla padrona.
– Non spaventate il signore, non ditegli niente Marta, – esclamò la Signora Claes.
– Povere, care figliuole, – aggiunse stringendosi al cuore Margherita e Felicita con un moto disperato, – vorrei poter vivere abbastanza per vedervi felici e sposate. Marta, –– riprese, – dite a Lemulquinier di andar dal signor De Solis per pregarlo da parte mia di venir qui.
Questo fulmine si ripercosse naturalmente fino in cucina. Josette e Marta affezionate ambedue alla signora Claes ed alle figliole furono colpite nel solo affetto che avessero! Queste parole terribili, "la signora muore, sarà il signore che l’avrà uccisa, fate presto un bagno senapato ai piedi!" avevano strappato molte interiezioni a Josette che ne faceva responsabile Lemulquinier. Questi, freddo e insensibile, mangiava seduto ad un lato della tavola, davanti ad una delle finestre dalla quale la cucina riceveva luce dal cortile, ove tutto era pulito come nel salotto di una giovane amante.
– Doveva finir così – diceva Josette guardando il cameriere e salendo su di uno sgabello per prendere da una mensolina un limone che luccicava come oro. – Non c’è nessuna madre che possa vedere a sangue freddo un padre che dilapida una sostanza come quella del signore senza concludere nulla.
Josette, il cui capo ornato di una cuffia rotonda a gale increspate somigliava a quello di uno schiaccianoci tedesco, lanciò a Lemulquinier uno sguardo, che il colore verde dei suoi occhietti rendeva quasi velenoso. Il vecchio cameriere alzò le spalle con un movimento deono di Mirabeau impazientito, poi infornò nella sua boccaccia una tartina di burro piena di leccornie.
– Invece di tormentare il signore, la signora dovrebbe dargli del denaro; saremmo presto ricchi da nuotar tutti nell’oro! Non ci manca che un cappello perché lo troviamo.....
– Ebbene voi che avete ventimila lire in risparmi, perché non li offrite al signore? E’ il vostro padrone! e siccome voi siete tanto sicuro dei suoi atti e dei suoi gesti....
– Voi non ne capite niente, Josette: fate scaldare la vostra acqua, – rispose il fiammingo interrompendo la cuoca.
– Ne capisco abbastanza per sapere che qui c’erano migliaia di lire di argenteria, e che voi e il vostro padrone ci avete dato fondo e che se vi si lascia andare avanti di questo passo, farete così bene di cinque soldi sei centesimi che non ci sarà fra poco più niente.
– E il signore, – disse Marta sopraggiungendo – ucciderà la signora per sbarazzarsi di una moglie che lo trattiene, e gl’impedisce di buttar via tutto. È in preda al demonio, questo si vede! Il meno che arrischiate, Mulquinier, è la vostra anima, se pur ne avete una, mentre qui tutti son desolati, Le signorine piangono come delle Maddalene, correte dunque a cercare il signor abate De Solis.
– Ho da fare per il signore a ordinare il laboratorio, – disse il cameriere. – E’ troppo lontano di qui il quartiere d’Esquerchin. Andateci voi.
– Guardate questo mostro! – disse Maria. – Chi farà il bagno ai piedi alla signora? volete lasciarla morire? Ha una congestione alla testa.
– Mulquinier, –disse Margherita giungendo dalla sala che precede la cucina, – tornando indietro, dal signor De Solis, pregherete il signor Pierquin il medico, di venir subito qui.
– Eh! voi andrete! – disse Josette.
– Signorina, il signore mi ha detto di mettere in ordine il laboratorio, – rispose Lemulquinier volgendosi alle due donne e guardandole con un’aria da padrone.
– Papà, – disse Margherita al signor Claes che scendeva in quel momento, – non potresti lasciarci Lemulquinier per mandarlo in città?
Ci andrai, brutto cinese, – disse Marta sentendo che il signor Claes metteva Lemulquinier agli ordini della figliola.
La poca affezione del cameriere per la casa era il grande argomento di litigio fra le due donne e Lemulquinier, la cui freddezza aveva avuto per conseguenza di aumentare l’attaccamento di Josette e della governante.
Questa lotta, in apparenza così da poco, influì molto sull’avvenire di questa famiglia, quando più tardi, si trovò ad aver bisogno di aiuti nella miseria. Baldassarre ricadde nella sua distrazione così che non s’accorse dello stato in cui si trovava Giuseppina. Prese Giovanni sulle ginocchia e lo fece saltare macchinalmente pensando al problema che da quel momento aveva la possibilità di risolvere. Vide portare l’acqua per i piedi della moglie, che non avendo avuto la forza di muoversi dalla poltrona dove si trovava era rimasta in sala. Guardò anche le figliole intente a occuparsi della madre, senza cercar la cagione delle loro cure sollecite. Quando Margherita o Giovanni facevano per parlare, la signora Claes imponeva loro silenzio additando Baldassarre. Una simile scena era tale da far pensare Margherita, che, posta fra il padre e la madre era grande abbastanza e già riflessiva per giudicarne la condotta. C’è un momento nella vita interiore delle famiglie nelle quali i figli sia volontariamente sia involontariamente diventano i giudici dei loro genitori. La signora Claes aveva compreso il danno di questa situazione. Per amore di Baldassarre cercava di giustificare agli occhi di Margherita ciò che nello spirito retto di una fanciulla di sedici anni potevano sembrar delle colpe in un padre. Così il rispetto profondo che la signora Claes dimostrava per lui in tale circostanza, abolendosi dinanzi a lui per non turbarne la meditazione, imponeva ai figli una specie di terrore per la maestà paterna. Ma questa devozione per quanto fosse contagiosa, aumentava ancor più l’ammirazione di Margherita per sua madre alla quale più specialmente la univano i casi della vita quotidiana. Questo sentimento era fondato sopra una specie di intuizione di sofferenze la cui causa doveva di necessità preoccupare una giovanetta. Nessuna potenza umana poteva impedire che talvolta una parola sfuggita sia a Marta, sia a Josette non rivelasse a Margherita l’origine della situazione nella quale si trovava la casa da quattro anni. Ad onta della discrezione della signora Claes, sua figlia dunque, insensibilmente, adagio, adagio, filo a filo, scopriva la trama misteriosa di questo dramma domestico, Margherita sarebbe diventata in un dato tempo, l’attiva confidente di sua madre e sarebbe nel momento decisivo il più temibile dei giudici. Così, tutte le cure della signora Claes erano rivolte a Margherita alla quale cercava di comunicare la sua devozione per Baldassarre. La fermezza, l’equilibrio che trovava nella figliola la facevano fremere all’idea di una possibile lotta fra Margherita e Baldassarre, quando, dopo la sua morte, l’avrebbe sostituita nella direzione della casa.
La povera donna era dunque giunta a temere più le conseguenze della sua morte che la sua morte stessa. La sua sollecitudine per Baldassarre si rivelava nella risoluzione che aveva preso or ora. Liberando i beni di suo marito ne assicurava l’indipendenza e preveniva ogni discussione separando i suoi interessi da quelli dei figli: sperava di vederlo felice fino al momento in cui chiuderebbe gli occhi, poi pensava di trasfondere le delicatezze del suo cuore in Margherita che presso di lui avrebbe continuato a sostenere la parte di angelo d’amore, esercitando sulla famiglia una autorità tutelare e conservatrice. Non era un far risplendere ancora dal fondo della sua tomba il suo amore per coloro che le erano cari? Tuttavia non volle esautorare il padre agli occhi della figlia iniziandola prima del tempo, ai terrori che le ispirava la passione scientifica di Baldassarre: studiava l’animo e il carattere di Margherita per sapere se la giovanetta sarebbe diventata da se stessa una madre per i suoi fratelli e sua sorella, per il padre una donna dolce e tenera. Così gli ultimi giorni della signora Claes curano avvelenali da calcoli e da timori che non osava confidare a nessuno. Sentendosi colpita nella vita stessa da quell’ultima scena, spinse lo sguardo più innanzi nell’avvenire; mentre Baldassarre ormai incapace a tutto ciò che era economia, guadagno, sentimenti domestici, pensava a trovar l’assoluto.... Il profondo silenzio che regnava nella sala non era rotto che dal movimento monotono del piede di Claes che continuava ad alzarlo senza accorgersi che Giovanni era disceso.
Seduta vicino alla madre della quale contemplava il viso pallido e contraffatto, Margherita si volgeva ogni tanto verso suo padre, stupita della sua insensibilità. Tosto la porta di strada risuonò rinchiudendosi e tutti videro l’abate De Solis appoggiato al nipote attraversare insieme lentamente il cortile.
– Ah, ecco il signor Emanuele – disse Felicita.
– Il buon giovane – disse la signora Claes scorgendo Emanuele De Solis – sono contenta di rivederlo.
Margherita arrossì, sentendo l’elogio che sfuggiva a sua madre. Da due giorni l’aspetto del giovane aveva risvegliato nel suo cuore sentimenti ignoti, e fatto nascere pensieri fino allora non mai avuti. Durante la visita che il confessore aveva fatto alla sua penitente erano accaduti fatti impercettibili che hanno gran parte nella vita, e i cui risultati furono abbastanza importanti per richiedere che, a questo punto, si descrivano i due personaggi nuovi introdotti nell’intimità della famiglia.
La signora Claes aveva per principio di adempiere segretamente alle sue pratiche religiose. il suo direttore spirituale, quasi sconosciuto in casa sua, solo per la seconda volta vi compariva; ma qui, come altrove, si era presi da una specie di commossa ammirazione alla vista dello zio e del nipote. L’abate De Solis, vecchio di ottant’anni, dai capelli d’argento, aveva un viso decrepito nel quale pareva che la vita si fisse concentrata negli occhi. Camminava a stento perché una delle due gambe sottili terminava con un piede orribilmente deformato, racchiuso in una specie di sacco di velluto che lo costringeva a servirsi di una gruccia quando non aveva il braccio del nipote. La schiena ricurva, il corpo scarno offrivano lo spettacolo di un essere sofferente e gracile, dominato di una volontà di ferro e da un casto fervore religioso che l’aveva sorretto. Questo prete spagnolo noto per un vasto sapere, per una vera pietà per le sue conoscenze molto estese, era stato successivamente domenicano, gran penitenziere di Toledo, e vicario generale dell’episcopato di Malines. Senza la Rivoluzione francese, la protezione dei Casa Réal lo avrebbe fatto giungere alle più alte dignità della Chiesa; ma il dolore che gli aveva procurato la morte del giovane duca suo scolaro gli aveva dato il disgusto della vita attiva ed egli s’era consacrato tutto quanto all’educazione del nipote rimasto presto orfano. Al tempo della conquista del Belgio si era stabilito presso la signora Claes. Fin dalla sua giovinezza l’abate De Solis aveva nutrito per S. Teresa un entusiasmo che lo aveva portato, secondo anche l’inclinazione del suo spirito, verso l’aspetto mistico del cristianesimo. Nelle Fiandre, dove la signorina Bourignon aveva fatto, come gli scrittori più illuminati e quietisti, il maggior numero di proseliti, trovando un gruppo di cattolici simpatizzanti alle sue credenze, rimase tanto più volentieri in quanto venne considerato come un patriarca da questa comunità particolare dove continuano a sopravvivere le dottrine dei mistici, malgrado le censure che colpirono Fénelon e la signora Guyon. I suoi costumi erano severi, la vita esemplare, e si diceva che avesse delle estasi. Malgrado il distacco dalle cose di questo mondo, che un religioso così austero doveva praticare, l’affetto per il nipote lo rendeva curante dei propri interessi. Quando si trattava di un’opera di carità il vecchio faceva contribuire i fedeli della sua chiesa prima di ricorrere alla propria sostanza e le sue intenzioni erano così pure, la sua perspicacia così di rado falliva che tutti facevano onore alle sue richieste. Per avere un’idea del contrasto che formavano lo zio e il nipote, bisognerebbe paragonare il vecchio ad uno di quei salici cavi che crescono in riva all’acqua e il giovane uomo ad una pianta di rose selvatiche carica di fiori il cui stelo elegante e schietto si innalza dal seno dell’albero muscoso che sembra voler tener diritto.
Cresciuto severamente vicino allo zio che lo custodiva presso di lui come una matrona custodisce una vergine, Emanuele era pieno di quella attraente sensibilità, di quel candore mezzo–sognante, fiori caduchi di ogni giovinezza, ma freschi nelle anime nutrite di principi religiosi. Il vecchio prete aveva soffocato nel suo allievo, l’espressione dei sentimenti voluttuosi preparandolo alle sofferenze della vita con continue fatiche e con una disciplina quasi claustrale. Questa educazione che doveva lasciare l’inesperto Emanuele in balia del mondo e renderlo felice se fosse stato fortunato nei suoi primi affetti, l’aveva rivestito di una purezza angelica che dava alla sua persona il fascino di una giovanetta. I suoi sguardi timidi ma sostenuti da uno spirito forte e coraggioso, mandavano una luce che si spargeva nell’anima come il suono di un cristallo comunica le sue vibrazioni all’orecchio. Il suo viso espressivo, per quanto regolare, ispirava simpatia per la nettezza dei contorni e per la felice disposizione dei lineamenti; e per la calma profonda che infondeva la pace nel cuore. Tutto vi era armonico. I capelli neri, gli occhi e le sue brune sopracciglia davano un maggior risalto alla pelle bianca e al viso colorito. La voce era quale si aspettava da un viso così bello. I movimenti femminei erano in armonia colla melodia della voce e colla tenera chiarità dello sguardo. Egli sembrava ignorare l’attrattiva che esercitavano il riserbo tinto di melanconia del suo atteggiamento, quello delle sue parole, e le cure rispettose che aveva per lo zio. A vederlo studiare il passo tortuoso del vecchio abate per adeguarsi alle sue dolorose deviazioni così da non contrariarlo; guardando fin da lontano ciò che poteva ferirgli i piedi e dirigendolo su una strada migliore, era impossibile non riconoscere in Emanuele i generosi sentimenti che rendono l’uomo una creatura sublime. Sembrava così grande, amando suo zio senza giudicarlo, obbedendogli senza mai discutere i suoi ordini, che ognuno voleva vedere una predestinazione nel nome soave che gli aveva dato la sua madrina. Quando, sia in casa sua, sia dagli altri, il vecchio esercitava il suo despotismo di domenicano, Emanuele alzava qualche volta la testa con tanta nobiltà, come per affermare se si trovava alle prese con un altro uomo, la sua forza, che la persone di cuore ne erano commosse come lo sono gli artisti alla vista di una grande opera; perché i buoni sentimenti non echeggiano meno fortemente nell’animo, nelle creazioni vive che nelle opere d’arte.
Emanuele aveva accompagnato suo zio quando ,era venuto dalla sua penitente per esaminare i quadri di casa Claes. Sentendo da Marta che l’abate de Solis si trovava nella galleria, Margherita che desiderava vedere questo uomo famoso, aveva cercato qualche pretesto menzognero per raggiungere la madre, a fine di soddisfare la sua curiosità. Entrata, distrattamente, affettando quella leggerezza sotto la quale le giovinette nascondono così bene i loro desideri, aveva incontrato vicino al vecchio vestito di nero, curvo, malandato, cadaverico, la fresca deliziosa persona di Emanuele. Gli sguardi ugualmente giovani, ugualmente ingenui di questi due esseri avevano espresso lo stesso stupore. Emanuele e Margherita s’erano già visti l’uno e l’altro nei loro sogni. Tutti e due chinarono gli occhi e tutti e due li alzarono poi con uno stesso movimento, lasciando sfuggire una medesima confessione. Margherita prese il braccio di sua madre, le parlò a bassa voce per contegno, e si rifugiò, per così dire, sotto l’ala materna, tenendo fuori il collo con un movimento di cigno, per rivedere Emanuele, che, da parte sua, rimaneva serrato al braccio dello zio. Per quanto ben distribuita per mettere in buona luce le tele, la debole luce della galleria favorì queste occhiate furtive che formano la delizia dei timidi. Senza dubbio nessuno di loro giunse, nemmeno col pensiero, al sì con cui cominciano le passioni; ma tutt’e due provarono quel turbamento profondo che agita il cuore e intorno al quale da giovani si mantiene a se stessi il segreto per goderlo meglio, o per pudore. La prima impressione che provoca il traboccare di una sensibilità trattenuta per molto tempo, è seguita, in tutti i giovani, dallo stupore a metà stupido, che producono nei bambini i primi suoni musicali. Alcuni dei fanciulli ridono, e pensane; altri non ridono che dopo aver pensato; ma quelli la cui anima è destinata a vivere di poesia e d’amore ascoltano per molto tempo e chiedono di nuovo la melodia con uno sguardo nel quale si illumina già il piacere o spunta la curiosità dell’infinito. Se noi amiamo irresistibilmente i luoghi dove nella nostra infanzia siamo stati iniziati alle bellezze dell’armonia, se noi con gioia ci ricordiamo e del musicista e perfino dello strumento, come non amare l’essere che per il primo ci rivela la musica della vita? Il primo cuore nel quale noi abbiamo aspirato all’amore non è come una patria?
Emanuele e Margherita furono l’uno per l’altra questa voce musicale che risveglia un senso, la mano che solleva dei fitti veli, e mostra le rive illuminate dallo splendore meridiano. Quando la signora Claes fermò l’attenzione del vecchio dinanzi ad un quadro del Guide che rappresentava un angelo, Margherita sporse la testa per vedere quale sarebbe stata l’impressione di Emanuele e il giovane cercò Margherita per paragonare il muto pensiero della tela al pensiero vivo della creatura. Questa involontaria e inebriante lusinga fu compresa e gustata.
Il vecchio abate lodava con gravità questa bella composizione e la signora Claes gli rispondeva; ma i due giovani erano silenziosi. Tale fu il loro incontro. La luce misteriosa della galleria, la quiete della casa, la presenza dei genitori, tutto contribuì a imprimere sempre più le linee delicate di questo vaporoso miraggio. I mille confusi pensieri che si erano agitati in Margherita si quietarono, produssero nella sua anima conte una limpida distesa e si tinsero di un raggio luminoso quando Emanuele balbettò qualche frase congedandosi dalla signora Claes. Questa voce il cui timbro fresco e vellutato infondeva nel cuore incanti inauditi, terminò la improvvisa rivelazione che Emanuele aveva provocata e che doveva fecondare a suo vantaggio; poiché l’uomo del quale il destino si serve per risvegliare l’amore nell’animo di una giovinetta ignora spesso la sua opera e la lascia allora incompleta.
Margherita si chinò tutta interdetta e mise il suo saluto in uno sguardo dove pareva riflettersi il rimpianto di perdere questa pura e affascinante visione. Come il bambino essa voleva ancora la sua melodia. Questo saluto avvenne ai piedi del
vecchio scalone davanti alla porta della sala, e quando vi entrò guardò lo zio e il nipote fino a che la porta di strada fu rinchiusa. La signora Claes era stata troppo preoccupata dei gravi argomenti discussi nel colloquio col suo direttore, per aver avuto l’agio di esaminare la fisionomia della figlia. Nel momento in cui il signor De Solis e solo nipote comparivano per la seconda volta, essa era troppo profondamente sconvolta per accorgersi del rossore che imporporò il viso di Margherita rivelando quanto aveva operato la prima gioia nel cuore di una vergine.
Quando il vecchie abate venne annunciato, Margherita riprese il suo lavoro e sembrò mettervi tanta attenzione che salutò lo zio e il nipote senza guardarli. Il signor Claes rese macchinalmente il saluto all’abate De Solis e uscì dalla sala come chi è preso dai propri pensieri. Il pio domenicano si sedette vicino alla sua penitente gettandogli delle profonde occhiate colle quali scrutava le anime: gli era bastato di vedere il signor Claes e sua moglie per intuire una catastrofe.
–– Figli miei, – disse la madre, – andate in giardino. Margherita, mostra ad Emanuele i tulipani di tuo padre.
Margherita un po’ vergognosa, prese il braccio di Felicita, guardò il giovane uomo che arrossì e uscì dalla sala prendendo, per contegno, Giovanni. Quando furono tutti e quattro in giardino, Felicita e Giovanni andarono per conto loro e lasciarono Margherita che, rimasta quasi sola col giovane de Solis, lo condusse davanti all’aiuola dei tulipani sempre disposti ogni anno nel medesimo modo, da Lemulquinier.
– Amate i tulipani? – chiese Margherita dopo essere rimasta un momento nel più profondo silenzio senza che Emanuele sembrasse volerlo rompere.
– Signorina, sono bei fiori, ma per amarli bisogna senza dubbio che piacciano e che se ne sappia apprezzare la bellezza. Questi fiori mi abbagliano.’ L’abitudine al lavoro, nell’oscura, piccola camera nella quale sto vicino a mio zio, mi fa senza dubbio preferire quello che è d’aspetto delicato.
Proferendo queste ultime parole contemplò Margherita, ma senza che questo sguardo pieno di desideri confusi contenesse allusione alcuna alla bianchezza opaca, alla calma, ai colori delicati che rendevano questo viso simile a un fiore.
– Voi lavorate dunque molto? ~– riprese Margherita conducendo Emanuele verso una panchina di legno collo schienale, dipinta di verde. – Da questo punto non vedrete i tulipani così da vicino e poi daran meno noia agli occhi. Avete ragione, questi colori abbagliano e fanno male.
– A che lavoro? – rispose il giovane dopo un momento di silenzio durante il quale aveva spianato col piede la sabbia del viale. – Lavoro intorno a ogni genere di cose. Mio zio voleva farmi prete....
– Oh!– fece ingenuamente Margherita.
– Ho resistito, non me ne sentivo la vocazione. Ma ho avuto molto coraggio per ostacolare i desideri di mio zio. È così buono e mi vuol tanto bene! Ultimamente ha pagato un tale per esimere dal servizio militare, me, povero orfano.
– A che volete dunque dedicarvi? – chiese Margherita che sembrò voler riprendere il discorso, lasciandosi sfuggire un gesto e aggiungendo:
– Scusate signore, voi dovete trovarmi ben curiosa...
– Oh, signorina, – disse Emanuele guardandola con ammirazione e tenerezza insieme, – nessuno, tranne mio zio, non mi ha ancor rivolto questa domanda. Studio per diventar professore. Che volete? Io non sono ricco. Se posso divenire il direttore di un collegio in Fiandra, avrò di che vivere modestamente e sposerò una donna semplice che amerò. Tale è la vita che ho dinanzi. Forse è per questo che preferisco una pratolina su cui passan tutti nella pianura di Orchies, a questi bei tulipani pieni d’oro, di porpora, di zaffiri e di smeraldi che rappresentano una vita fastosa, così come la pratolina simboleggia una vita dolce, patriarcale, la vita di un povero professore come sarò io.
– Finora io avevo sempre chiamato le pratoline, margherite, – disse essa.
Emanuele de Solis arrossì troppo e cercò una risposta tormentando la sabbia coi piedi. Impacciato nella scelta di tutte le idee che gli venivano e che trovava sciocche, e poi imbarazzato dall’indugio con cui rispondeva, disse:
– Non osavo pronunciare il vostro nome... – e non terminò.
– Professore! – riprese essa.
– Oh, signorina, io sarò professore per avere una posizione, ma mi darò ad opere che potranno rendermi assai più utile. Ho molta simpatia per gli studi storici.
– Ah!
Questo ah! pieno di pensieri reconditi rese il giovane uomo ancor più vergognoso ed egli si mise a ridere scioccamente dicendo:
– Voi mi fate parlare di me, signorina, quando non dovrei parlare che di voi.
– Mia madre e vostro zio han finito, credo, la loro conversazione, – disse guardando attraverso alla finestra, nella sala.
– Ho trovato la signora vostra madre assai mutata.
– Essa soffre senza volerci dire la causa delle sue sofferenze, e a noi non resta che soffrire dei suoi dolori.
La signora Claes aveva infatti finito una consultazione delicata nella quale trattava di un caso di coscienza che l’abate de Solis solo poteva decidere. Prevedendo una rovina completa, essa voleva prelevare, all’insaputa di Baldassarre, che si occupava poco dei suoi affari, una somma considerevole sul prezzo dei quadri che il signor de Solis si incaricava di vendere in Olanda, per tenerla nascosta e serbarla per il momento nel quale la miseria si sarebbe fatta sentire. Dopo matura riflessione e dopo aver considerate le circostanze nelle quali si trovava la sua penitente, il vecchio domenicano aveva approvato questo atto di prudenza.
Egli partì per occuparsi di questa vendita, che doveva avvenire in segreto per non nuocer troppo alla reputazione del signor Claes, e mandò il nipote, munito di una lettera di raccomandazione, ad Amsterdam dove il giovane felice all’idea di rendersi utile alla casa Claes, riuscì a vendere i quadri della galleria ai celebri banchieri Happe e Dunker per una somma dichiarata di ottantacinquemila ducati di Olanda, e una somma di altri quindicimila che sarebbe stata consegnata in segreto alla signora Claes. 1 quadri erano così noti che per stringere il contratto bastava la risposta di Baldassarre alla lettera che gli indirizzava la casa Happe e Dunker. Emanuele de Solis fu da Claes incaricato di ricevere il prezzo dei quadri che gli inviò segretamente per non far conoscere alla città di Douai la notizia di questa vendita. Verso la fine di settembre Baldassarre restituì le somme che gli erano state prestate, svincolò i suoi beni e riprese i suoi lavori; ma la casa Claes si era spogliata del suo più bell’ornamento.
Accecato dalla passione non manifestò un rimpianto, tanto egli si credeva certo di poter subito rimediare a questa perdita poiché, aveva fatto la vendita col patto del riacquisto. Cento tele dipinte non eran niente agli occhi di Giuseppina al confronto della felicità domestica e della soddisfazione di suo marito: fece riempire la galleria coi quadri che ornavano le sale da ricevere e per dissimulare il vuoto che restava nell’appartamento anteriore, mutò la disposizione dei mobili. Pagati i debiti, Baldassarre ebbe circa duecentomila lire a sua disposizione per ricominciare le sue ricerche. L’abate de Solis e il nipote furono i depositari dei quindicimila ducati riserbati alla signora Claes. Per aumentare questa somma l’abate vendette i ducati che le sorti della guerra continentale aveva aumentati di valore. I sessantasei mila franchi in scudi furono sotterrati nella cantina della casa abitata dall’abate de Solis. La signora Claes ebbe la triste soddisfazione di vedere suo marito sempre occupato per otto mesi. Tuttavia troppo gravemente tocca dal colpo che le aveva inferto, cadde malata di un esaurimento che doveva necessariamente peggiorare. La scienza assorbì completamente Baldassarre che né i rovesci della Francia, né la prima caduta di Napoleone, né il ritorno dei Borboni lo distrassero dalle sue occupazioni, non era più né marito, né padre, né cittadino– fu chimico. Verso la fine del 1814 la signora Claes era giunta ad un tale stato di sfinimento da non poter più abbandonare il letto. Non volendo vegetare nella camera ove aveva vissuto felice, ove il ricordo della gioia perduta le avrebbe suggerito involontari paragoni col presente che l’avrebbero abbattuta, rimaneva in sala. I medici avevano favorito i voti del suo cuore trovando questa camera più ariosa e più gaia e più adatta al suo stato, che la sua. Il letto, dove la disgraziata donna finiva di vivere fu posto fra il camino e la finestra che dava in giardino. Passò là i suoi ultimi giorni santamente occupata a perfezionare l’anima delle sue due figliole sulle quali si compiacque di far risplendere la luce della sua. Diminuito nelle sue manifestazioni, l’amore coniugale permise all’amore materno di esplicarsi. La madre si mostrò tanto più magnifica quanto più aveva tardato ad essere così. Come tutte le persone generose provava sublimi delicatezze di sentimento che scambiava per rimorsi. Credendo di aver sottratto qualche tenerezza dovuta ai suoi figli, cercava di riparare ai suoi torti immaginari avendo per essi delle cure e delle premure che la rendevano ad essi cara; voleva in qualche modo farli vivere insieme col suo cuore, aprirli colle sue ali stanche e amarli in un giorno per tutti quelli nei quali in vita li aveva trascurati. Le sofferenze davano alle sue carezze, alle sue parola un tepore insinuante che emanava dalla sua anima. Gli occhi carezzavano i suoi figlioli prima che la voce li commuovesse con intonazioni piene di affettuosità e la sua mano sembrava versare sempre su di loro delle benedizioni.
Se, dopo aver ripreso le sue abitudini di lusso, in casa Claes presto non si ricevette più nessuno, se il suo isolamento divenne più completo, se Baldassarre non diede più feste all’anniversario del suo matrimonio, la città di Douai non ne rimase sorpresa. Dapprima la malattia della signora Claes parve una ragione sufficiente di questo cambiamento, poi il pagamento dei debiti troncò le maldicenze, infine le vicende politiche a cui fu soggetta la Fiandra, la guerra dei Cento giorni, la occupazione straniera, fecero completamente dimenticare il chimico. Durante questi due anni la città fa cosi spesso occupata sia dai francesi, sia dai nemici, vi convennero tanti stranieri, vi si rifugiarono tanti contadini, ci furono tanti interessi messi sossopra, tante esistenze messe in forse, tanti cambiamenti e tante disgrazie, che ciascuno non poteva che pensare a sé.
L’abate de Solis con suo nipote e i fratelli Pierquin essendo le sole persone che venissero a far visita alla signora Claes, l’inverno del 1814–15 costituì per lei la più dolorosa delle agonie. Suo marito veniva a trovarla raramente; rimaneva sì, dopo pranzo, per qualche ora vicino a lei, ma siccome essa non aveva più la capacità di sostenere a lungo la conversazione diceva una o due frasi eternamente uguali, si sedeva, taceva, e lasciava pesare nella sala un silenzio orribile. Questa monotonia era rotta solo nei giorni nei quali l’abate de Solis e suo nipote passavano la sera in casa Claes. Mentre il vecchio giocava a tric–trac con Baldassarre, Margherita discorreva con Emanuele vicino al letto della madre che sorrideva alle loro gioie innocenti senza far trapelare quanto per la sua anima martoriata fosso a un tempo doloroso e buono il fresco alito di questi amori verginali, che traboccavano a ondate da una parola all’altra.
L’inflessione di voce, che affascinava i due giovani le spezzava il cuore; un’occhiata di intelligenza sorpresa fra di loro la rimandava, lei quasi morta, ai ricordi delle sue ore giovani e felici, ricordi che davano al presente tutta la sua amarezza. Emanuele e Margherita avevano una delicatezza tale da trattenersi nel loro delizioso scherzare amoroso per non offendere una donna addolorata le cui ferite, erano per istinto, da loro intuite. Nessuno ha ancor notato che i sentimenti hanno una vita loro propria, un carattere che deriva dalle circostanze nelle quali sono sorti. Essi mantengono la fisionomia dei luoghi dove si son svolti e l’impronta delle idee che hanno contribuito al loro svolgimento. Ci sono delle passioni concepite con ardore che restano sempre ardenti come quella della signora Claes per suo marito; ci son poi sentimenti ai quali tutto ha arriso che mantengono una letizia mattinale, le loro messi di gioia non sono mai senza risa e feste; ma si danno anche amori incorniciati, per fatalità, di melanconia o circondati dal dolore, le cui gioie sono penose, difficili, piene di timori avvelenate dai rimorsi e piene di disperazione. L’amore sepolto nel cuore di Emanuele e di Margherita senza che ancor nessun dei due comprendesse che si trattava di amore, questo sentimento sbocciato sotto la cupa volta della galleria Claes, davanti ad un vecchio abate severo, in un momento di silenzio e di calma, questo amore grave e discreto, ma ricco di tinte dolci, di voluttà segrete, assaporate come un grappolo rubato in un angolo di un vigneto, subiva il colore bruno, le tinte grigie che lo avevano colorato nei primi momenti. E, non osando lasciarsi andare a nessuna manifestazione un po’ viva davanti a questo letto di dolore, i due figlioli aumentavano a loro insaputa i loro godimenti con una concentrazione che li teneva rinchiusi in fondo al cuore. Erano le cure prestate alla malata, e alle quali Emanuele desiderava partecipare, felice di potersi unire a Margherita, facendosi in anticipazione figlio di questa madre. Un malinconico ringraziamento sostituiva, sulle labbra della giovinetta, il melato linguaggio degli amanti. I sospiri del loro cuore, pieno di gioia per qualche sguardo scambiato, poco si distinguevano dai sospiri strappati dalla vista del dolore materno. I loro brevi momenti buoni di confessioni indirette di promesse incomplete, di slanci trattenuti potevano essere paragonati a quelle allegorie dipinte da Raffaello su sfondi neri, l’uno e l’altra avevano una certezza che non si confessavano, sapevano che c’era il sole sopra di loro, ma ignoravano quale vento avrebbe dissipato le nubi oscure che erano addensate sulle loro teste; dubitavano dell’avvenire e temevano di dover sempre aver a compagna la sofferenza, e restavano timidamente nell’ombra di questo crepuscolo senza osare di dirsi: termineremo insieme la giornata? Tuttavia la tenerezza che la signora Claes prodigava, nascondeva nobilmente tutto ciò che taceva di se stessa. I suoi ragazzi non le procuravano né turbamento, né dolore, erano la sua consolazione, ma non erano la sua vita: essa viveva per loro, ma moriva per Baldassarre. Per quanto penosa potesse essere per lei la presenza di suo marito pensieroso per ore intere, che le dava ogni tanto un’occhiata monotona, non obliava i suoi dolori che durante quei crudeli momenti. L’indifferenza di Baldassarre per questa donna morente sarebbe sembrata criminale ad un estraneo che ne fosse stato testimonio; ma la signora Claes e le figliole v’erano avvezze; conoscevano il cuore di questo uomo e lo assolvevano.
(Fine della quinta parte)