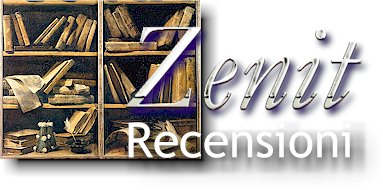|
Fare chiarezza nelle
vicende massoniche di ieri, così come in quelle di oggi, non è semplice, per la
facilità con cui estimatori e detrattori continuano, da quasi 300 anni, a creare una
cortina di false informazioni, gli uni per demonizzare gli altri per esaltare
l’Istituzione.
Polo Friz ha setacciato per lunghi anni archivi e biblioteche di mezza Europa con
l’entusiasmo del neofita e la passione del ricercatore. La ricostruzione storica che
ne è risultata è precisa e accurata. Aggiungiamo anche che è ben lontana da una certa
immagine della massoneria che i pochi studiosi dell’Istituzione italiana da anni
stanno cercando di sostituire con una più veritiera.
La sua storia inizia con l’unità d’Italia e pour cause. Solo da quel
momento si può infatti parlare di una Istituzione organizzata sul territorio italiano. A
partire dalla Restaurazione in Italia ci furono solo logge isolate e più o meno
clandestine. Nessun documento può far ritenere che ci sia stata una qualche forma di
attività coordinata e finalizzata. Non è questione di secondaria importanza se si
riflette alle accuse degli avversari dell’unificazione nazionale che bollarono come
«massonico» tutto il processo risorgimentale italiano.
L’Istituzione massonica rinacque nel 1859 in quella Torino che si accingeva a
diventare la capitale del nuovo Stato. Collocata nell’ambito di una entità politica
in fase di consolidamento, non sfuggì all’influenza della vita profana.
Seguire i primi decenni della sua vita non è agevole. È un susseguirsi di aggregazioni e
disaggregazioni, di tentativi di personalità forti di imporre il proprio progetto, la
propria immagine di Massoneria.
Si ripropose nelle logge la stessa divisione già presente nel mondo politico: da
una parte i liberal moderati filogovernativi, dall’altra i democratici. Il Grande
Oriente Italiano nacque cavouriano, ma era destinato a veder prevalere al suo interno
l’elemento democratico chiaramente maggioritario. A Govean, Buscalioni, Nigra,
Cordova, subentrarono Crispi, Garibaldi, Dolfi, Pianciani, Mazzoni.
Presto si manifestò il contrasto tra i riti, formalmente in nome dell’autonomia
della nuova Comunione dal vicino Grand Orient de France, in realtà per imporre la
supremazia d’un gruppo sugli altri. A Palermo, Napoli, Milano, Torino risiedevano i
centri più importanti in continuo conflitto dialettico, al di là del conclamato - da
tutti - desiderio di unità.
Nel 1864 Lodovico Frapolli, un personaggio cui Polo Friz da dedicato quasi tutti i suoi
scritti, pubblicò uno scritto importante destinato a delineare la via che i massoni
italiani dovevano percorrere. «L’elaborato da lui predisposto doveva porre fine alla
scomposta vita massonica nazionale, che fino ad allora era vissuta richiamandosi a
tradizioni vetuste o fumose, o a statuti e regolamenti quasi mai citati. Aveva inoltre un
obbiettivo primario: quello di soddisfare all’esigenza di far coesistere i diversi riti»
(p.78). Dal testo emergeva anche evidente la volontà di fare delle logge centri di
mediazione dove superare le dispute quotidiane e ricercare linguaggi comuni.
Dall’insieme appariva evidente l’influsso francese, coniugato con la tensione
ideale del secolo dei Lumi. Frapolli, con questo suo lavoro, offrì all’Istituzione
una base ideologica fondata sulle scienze positive. «Il suo credo era un compendio delle
culture di avanguardia del secolo».
Egli era fondamentalmente un uomo d’azione destinato a lasciare il segno nella storia
del primo decennio di attività del Grande Oriente in Italia, una piccola Comunione che
stava cercando a fatica di legittimarsi nella confusione e nella mescolanza di logge e
gruppi, ognuno dei quali rivendicava a se stesso il ruolo di leadership. Al Supremo
Consiglio di Palermo retto da Garibaldi prima e da Campanella poi, Polo Friz dedica molte
pagine. Altrettante ne dedica a quella incredibile figura di abilissimo lestofante che
rispondeva al nome di Domenico Angherà che dominò la Napoli massonica dall’unità
al 1877. Ne viene fuori il quadro di una massoneria estremamente frammentata e litigiosa,
nella quale ognuno cercava di difendere al oltranza il suo fazzoletto di potere massonico.
Nel 1868 la situazione appariva veramente critica e Frapolli dovette impegnare tutta la
sua abilità organizzativa per ridare vita e scopo ad una Istituzione che stava morendo
d’inedia.
Una delle questioni più dibattute quando si affronta l’argomento massoneria riguarda
il ruolo dei massoni nel processo risorgimentale italiano. Quale è stato il loro
contributo all’unificazione? Secondo Polo Friz questo contributo va limitato ai
tentativi, ripetuti da Garibaldi nel corso degli anni sessanta, di arrivare a Roma per
farne la capitale d’Italia. Ad Aspromonte e a Mentana la presenza massonica non
sarebbe stata casuale.
Grande il coinvolgimento dei massoni di tutta la penisola, nell’estate del 1870, per
spingere il governo ad «andare a Roma». Fu forse questa la prima volta che i massoni
italiani si impegnarono coralmente avendo in mente un obiettivo comune. Un po’ poco
per considerare tutto il complesso processo di unificazione nazionale un «complotto
massonico».
La massoneria si sarebbe strutturata negli anni seguenti acquistando forza e forse
influenza, ma la conoscenza del suo faticoso inizio è di fondamentale importanza per
capire il divenire successivo degli eventi. In quel primo decennio l’Istituzione
cominciò a porsi quale centro di coagulo di una parte della classe dirigente
dell’Italia unitaria, quella più direttamente legata alle esperienze della sinistra
risorgimentale, che intendeva tener fermo il punto della laicità dello Stato e della
laicizzazione della vita pubblica e che sentiva l’esigenza dell’allargamento del
consenso verso più ampi strati dei ceti medi e delle popolazioni urbane che si andavano
politicizzando.
Il libro di Polo Friz è uno dei più seri e documentati contributi per avvicinarsi alla
complessa storia di questa Istituzione. L’Autore ha costruito la sua ricerca partendo
dal ricco fondo delle Carte Frapolli in suo possesso, che ha integrato con la
documentazione rinvenuta in un incredibile numero di archivi italiani e stranieri.
Anna Maria Isastia |